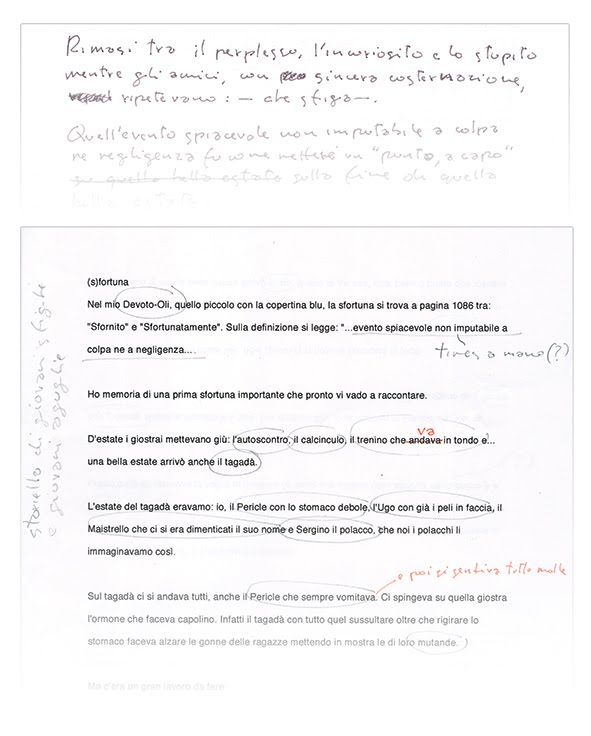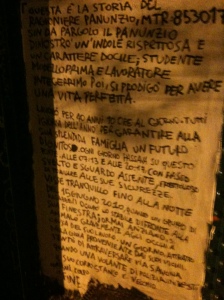di Sba
Io con la sfiga ci vivo benissimo, fin da quando sono nato. A quanto pare è la mia figura che funge da calamita, non sono io che sono sfigato. Sono praticamente circondato da gente che con la sfiga ci ha fatto le nozze, al punto che a volte mi chiedo se sono io a portare sfiga. Fin da quando sono nato.
La gente che è nata con me, nello stesso periodo, era tutta nella stanza dove sono nato io, o nei paraggi, non so bene. Uno che è nato il mio stesso giorno, nello stesso ospedale, nella stessa stanza, è venuto a scuola con me per anni, ed era uno veramente sfigato. Non era cresciuto molto, era piccolino, e tutti lo sfottevano perché era piccolino, e sfigato. Alle figurine riusciva a perdere anche contro di me, che ero una sega. Lui, sfigato, piccolino, perdeva anche contro di me. Era così sfigato che nessuno voleva giocare a figurine con lui, e allora si trovava a giocare con me, e perdeva, sfigato.
Un altro che è nato qualche giorno prima di me adesso vive a trenta metri da casa mia. Non è piccolino, e a dirla tutta non è nemmeno tanto sfigato, ha una bella casa, una bella moglie, un bell’idraulico. Sarà che ha passato veramente pochi istanti con me, ma non è poi così sfigato. Certo, i capelli che sembrano stuccati da un gessino della Val Camonica non gli rendono l’aspetto così piacevole, ma questo non credo che sia solo sfiga, deve essere anche questione di parrucchiere, o di lacca, o di idraulico.
Ce n’è ancora uno, nato una settimana prima di me, che era anche nello stesso ospedale, nella stessa stanza, nello stesso periodo. Lui non so dire bene se è sfigato o no, ma non lo vedo mai con delle ragazze e allora penso che sia sfigato, o anche un tantino omosessuale. Che non è essere sfigati, l’essere omosessuali, è credo più una questione di culo, ecco. Lui è sfigato a giorni alterni, tanto per capirci. Un giorno aveva parcheggiato la macchina nuova – beh, nuova, aveva un mesetto – in strada, e quella sera qualche buontempone voleva fare uno scherzo a un vicino di casa, e ci ha incendiato la macchina, al vicino di casa, solo che forse non sapeva bene quale era la macchina del vicino di casa e allora ha incendiato quella del mio amico. Quando sono arrivati i pompieri c’era solo più la marmitta, poi uno dice la sfiga.
Anche mia mamma è stata presa dalla sfiga che mi circonda, e quando dovevo nascere è ovvio che oltre alla sfiga a circondarmi era anche e soprattutto lei, mia mamma, nel vero senso della parola. Le avevano detto che ero in ritardo e che sarei nato grosso, sui cinque chili, e lei era un tantino preoccupata, al punto che scriveva lettere alla famiglia dicendo “o si sono sbagliati loro o mi sono sbagliata io, ma questo qui non ne vuole sapere di uscire”. Mentre chiacchierava con le mamme di quelli che sono nati prima o durante, quelli che ho detto sopra, era preoccupata che loro uscivano e io stavo lì dentro al calduccio. Mio padre lavorava sessantadue ore al giorno perché a casa ne aveva già due, di cosi che mangiavano, e io sarei stato il terzo, e da quanto ero grosso aveva già deciso di uccidere il vitello grasso. Mia mamma era più pacata, anche se ansiosa, e lo rincuorava dicendogli che comunque per i primi tempi, come per gli altri due, ci avrebbe pensato lei a sfamarmi. E appena dopo nato le dissero subito che non aveva latte, e che io avrei dovuto passare i migliori anni della mia vita senza il contatto con le mammelle. Che poi ‘sta cosa delle mammelle me la porto ancora adesso, mi viene da metterci la faccia dentro ogni volta che le vedo, alle mammelle, vatti a sapere perché. Sfigato anch’io, niente mammelle, mi son dato alla birra fin dall’infanzia.
Quando giocavo con mia sorella, da bambino, si faceva sempre male lei, poverina. Gara con la bici, una spanna di pelle abrasa. Gara a salire sulla betulla, si rompevano i rami dalla sua parte. C’era l’influenza, la beccava sempre lei. A Natale le regalavano la Barbie, e lei detestava quella bambolozza bionda abbagasciata, e allora la prendevo io, la spogliavo e mettevo la faccia in mezzo alle tette, chissà mai perché. Un giorno volevamo fare come maicbongiorno e facevamo i quiz, solo che per fare i quiz bisognava avere il cartellone con il nome, e lei ne scrisse uno per me, che io non sapevo scrivere, e ci scrisse Carlo Puttana, immagino perché non avesse idea di cosa volesse dire Carlo. Poi arrivò mia madre e sorrise, a me, e a lei le mollò una chiantozza che le rimasero le dita istoriate sulla guancia per due giorni. Ci vollero ancora un paio d’anni per capire che aveva buoni motivi per tenermi alla larga.
Alle elementari dopo la scuola uscivo sempre di casa a far danni in giro per il quartiere, insieme al mio amico Luca. Lui non era mica sfigato, di suo, ma appena arrivavo io, tempo due o tre ore, gli capitava qualcosa di spiacevole. Andavamo a spaccare pignatte nelle case in costruzione, e i muratori beccavano lui e lo portavano a casa da suo padre che gli faceva dei culi che si sentiva urlare fin nelle campagne. Giocavamo nei prati, e le api pungevano solo lui. Gara in bici, trentatré centimetri di abrasioni per volta. I rami dei gelsi si rompevano sempre e solo dalla sua parte. Far le scalette con i chiodi del sette, sapessi le martellate che si dava sulle dita, solo lui, sfigato. Sua mamma aveva i capelli neri, suo papà aveva i capelli neri, lui aveva i capelli rossi e le lentiggini, e questo da bambino non significava sfiga, ma crescendo mi aveva fatto venire qualche sospetto. A volte prendevamo in prestito il carretto di suo padre, e andavamo in giro lui sopra e io dietro a spingere, correndo a piene balle per strade sterrate. A volte era lui a spingere e io sopra, e non succedeva niente, ma quando era lui sopra e io a spingere era sicuro che un sasso o una buca lo avrebbero fatto ribaltare. Quando è stato più grandicello ha finalmente risolto i suoi problemi, perché i miei mi avevano rinchiuso in un collegio.
A scuola, alle medie, avevo cambiato posto, al collegio, non ero più al paese, e questo avrebbe potuto farmi passare quell’aura da menagramo, che non lo sapevo mica ancora di averla a quel tempo, l’aura da menagramo, lo sto analizzando adesso. Conobbi un paio di compagni che venivano anche dal mio paese e feci amicizia. Dopo la scuola, in estate, finite le medie, ci vedevamo ogni tanto, e io cominciavo a trovare le ragazze, e ci piacevo alle ragazze, io, mentre loro erano sfigati e non avevano ancora baciato niente che fosse minimamente paragonabile a una forma di vita. Il mio amico Mario era proprio uno che sembrava attirare la sfiga su di sé, e sembrava che questo accadesse solo quando c’ero io. Se andavamo a fare un giro in motorino, lui forava sistematicamente. Se provava a elaborare il motore, grippava. Un giorno aveva finalmente trovato il modo di fare andare il suo Issimo più veloce del mio Califfo Giò, e tempo due giorni glielo avevano rubato. Allora era costretto a viaggiare sulla Vespa Primavera tre marce di suo padre, una casseruola di tale portata che sembra incredibile ancora adesso che possa essere esistita. Una volta la tirò fuori e io gli dissi Facciamo cambio, e lui prese il mio Califfo e io la sua Vespa, e andammo verso la strada della discarica, e non successe niente, anzi, la Vespa sembrava andare più del Califfo, e lui era contento, allora ci scambiammo di nuovo i motorini e quando ci salì sopra lui, tempo dieci metri, era forata.
Sarebbero ancora tanti gli esempi, ne dico solo più uno. Un giorno con dei colleghi di lavoro decidemmo di andare a fare un giro in bici, una cosa seria, fino a un rifugio in montagna. Quella mattina pioveva come dio la mandava, o il suo idraulico, non so bene, comunque pioveva e io passai a prendere uno dei miei colleghi col furgone, quello che ci hanno bruciato la macchina, come ho detto sopra, che non avevamo voglia di farci tutta la strada asfaltata in bici, e lui mi diceva Ma piove troppo, lasciamo perdere, e io gli dicevo Vedrai che arriviamo là e c’è il sole. E figurati, arrivati là c’era un sole caldo e il cielo sereno, e allora lui pensò che questa storia della sfiga era finita. Ci incamminammo, arrivammo in rifugio, arrivarono anche gli altri due colleghi più allenati e facemmo pranzo. A scendere, in rigoroso ordine cronologico, il collega A forò due volte, il collega B riuscì a incaprettarsi su dei sassi e forò tre volte in un tratto di appena trecento metri. Il collega venuto con me era praticamente sicuro di essere fuori pericolo quando in entrata di curva riuscì a fare una quindicina di metri sulle gengive. E bon, quei tre lì con me in bici non ci sono mai più voluti venire.
Dimenticavo, parlando di sfiga. Uno che era a scuola con me si è addirittura fatto prete.
[NYFT]